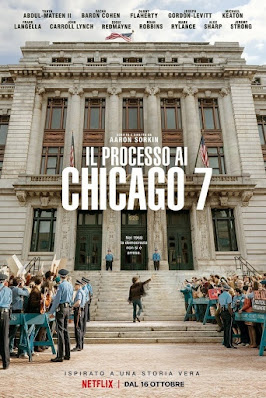"Palazzo di Giustizia" di Chiara Bellosi. Con Daphne Scoccia, Bianca Leonardi, Sarah Short, Nicola Rignanese, Giovanni Anzaldo, Andrea Lattanzi, Simone Moretto, Diego Benzoni e altri. Italia 2019 ★★★★
Ultimo film visto in sala dopo la demenziale decisione, contenuta nel più recente DPCM, di chiudere cinema, teatri e stadi (nemmeno a capienza più che ridotta) fino al 24 di novembre (per ora...), trattando ancora una volta gli italiani non da cittadini ma da sudditi o, se si vuole, da infanti irresponsabili. Un film insolito e coraggioso, quello d'esordio alla regìa di un lungometraggio di Chiara Bellosi, drammaturga milanese di solida formazione teatrale, che mantiene fede al suo titolo scegliendo di raccontare, con estremo realismo, ciò che accade davvero nella quotidianità di un grande tribunale italiano, in questo caso quello di Torino dove, in Corte d'Assise, si tiene il dibattimento finale di una causa che vede imputato per omicidio un benzinaio il quale, dopo essere stato assalito e rapinato dell'incasso, ha reagito inseguendo i due malviventi, aprendo il fuoco con la pistola regolarmente denunciata e ammazzandone uno: il sopravvissuto, Magia, è in aula in qualità di testimone. Essendo difficile sostenere la legittima difesa, gli avvocati suggeriscono all'imputato di dire di aver avuto paura; l'uomo, però, onestamente ammette che ciò che gli ha fatto scatenare la sua reazione è stata l'umiliazione, l'essersi dovuto inginocchiare e subire le minacce e le vessazioni dei due malviventi. Non è però questo il fulcro del film, benché la regista descriva con estrema attenzione e con abbondanza di primi piani e particolari veritieri le parole, i movimenti, le pause, gli sguardi di tutte le parti in causa, tant'è vero che al termine non viene resa nota la decisione presa in camera di consiglio dalla giuria, ma ciò che avviene fuori dall'aula e negli interminabili e freddi corridoi e meandri del palazzo, concentrandosi su Domenica, la figlia diciottenne del benzinaio, Luce, una bambina irrefrenabile che ne ha dieci di meno, figlia del rapinatore e di Angelina, la sua giovane compagna e convivente e le relazioni che si stabiliscono fra loro e con Daniele, un tecnico impegnato nella riparazione di un termosifone e che per tutta la giornata stazione nel corridoio antistante l'aula: spaccato di vita quotidiana all'interno del luogo in cui viene amministrata la giustizia, insomma, un mondo che, a ben vedere, con i suoi rituali, è estremamente vicino a quello del teatro, da cui per l'appunto la Bellosi proviene (ricordo anche che capitava, tra medie e liceo, di trascorrere in tribunale ad assistere ai processi come fossero spettacoli le mattinate in cui si marinava la scuola: il Palazzo di Giustizia di Milano era a poche centinaia di metri e veniva comodo). Belle inquadrature, nessun fronzolo, eccellente la scelta degli interpreti, poco noti ma tutti bravissimi, una gran bella sorpresa. Vivamente consigliato, per chi riesce a intercettarlo, prima o poi.